
Amiche e amici, come state? Io bene. Grazie alla mia lunga serie di traslochi recenti sono diventato cintura nera di Decluttering Estremo. E nell’ultimo di questi ho ritrovato con meraviglia buona parte dei ricordi legati alla mia precedente attività di Progettista e Gestore di Eventi Culturali (come da titolo da corso di Laurea di Lettere e Filosofia Uniba), di quando anni fa, mettendo insieme artisti di varie espressioni, davamo corpo a esposizioni, eventi e manifestazioni in una miscellanea di emozioni (un caleidoscopio) legate tra loro da un fil rouge, un tema, un significato, un concetto, un senso. Ma basta parlare di me in quanto artista raccattato, parassita e scippatore di emozioni, vediamo come lavorano quelli bravi e famosi.
Cosa succede quando una collezione d’arte incontra uno sguardo nuovo, irriverente, eppure profondamente sensibile? Succede The Large Glass, la mostra che al MAXXI non si limita a esporre le opere della collezione permanente, ma le rilegge attraverso la lente surreale – e lucidissima – di Alex Da Corte, artista e curatore di questa visione sfaccettata, quasi prismatica, del contemporaneo.



Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: The Large Glass rimanda inevitabilmente all’opera di Marcel Duchamp (La Mariée mise à nu par ses célibataires, même), ma non si tratta di un omaggio passivo. È un gesto di apertura, un invito a guardare attraverso una superficie trasparente ma mai neutra, dove l’arte si rifrange, si deforma e si moltiplica.
Da Corte seleziona, sposta, accosta e reinventa. Le opere non sono presentate per categorie, scuole o cronologie: si incontrano, si rispondono, si disturbano a vicenda. Così, un ricamo di Alighiero Boetti può trovarsi accanto a una video-installazione di Anna Franceschini, e il dialogo che ne nasce è straniante e rivelatore. Non c’è gerarchia, ma un fluire continuo di immagini, materiali, citazioni e intuizioni.



Uno degli aspetti più sorprendenti della mostra è l’insistenza sulla fisicità dell’opera d’arte: non più oggetto da contemplare, ma presenza viva, inquieta, talvolta ironica, spesso perturbante. Alex Da Corte ci invita a guardare le opere non solo “con” gli occhi, ma dentro gli occhi. E forse anche oltre.
Ne è un esempio il modo in cui le luci e i colori sono utilizzati per destabilizzare la nostra percezione. Ogni sala è costruita come una scena teatrale – talvolta intima, talvolta grottesca – in cui l’opera diventa personaggio e lo spettatore, suo malgrado, coprotagonista. Lo spazio è trattato come una partitura visiva e cromatica. Pareti verdi bottiglia, corridoi neri vellutati, dettagli di arredo volutamente stranianti: una sedia rovesciata su sé stessa, una tenda che non conduce da nessuna parte… Ogni elemento è progettato per disorientare, ma anche per accogliere lo sguardo in uno spazio altro.



Opere che brillano (e a volte disturbano)
1. Alighiero Boetti, “Mappa” (1989)
Un classico rivisitato dalla nuova prospettiva curatoriale: in questa sala, la celebre mappa ricamata, simbolo del mondo frammentato e sempre in mutazione, non è solo un’opera politica ma un corpo, una pelle, un costume. Da Corte la affianca a opere plastiche dalle forme antropomorfe, creando un cortocircuito visivo tra geopolitica e identità.
Curiosità: per i ricami della serie Mappa, Boetti collaborava con artigiane afghane, introducendo nel processo creativo un elemento di imprevedibilità e relazione. In questa mostra, la sua imprevedibilità trova una casa coerente.
2. Ed Atkins, “Warm, Warm, Warm Spring Mouths” (2013)
Il video di Atkins, potente e straniante, è come un’invocazione digitale alla corporeità perduta. Viene proiettato in una sala immersiva che Da Corte trasforma in uno spazio di spa post-umana: rilassante e inquietante al tempo stesso. Le labbra iperrealiste del personaggio parlano, ma il linguaggio sembra evaporato, come acqua calda.
3. Francesco Vezzoli, “Self-Portrait as Apollo del Belvedere with Karl Lagerfeld” (2009)
Da Corte non si tira indietro davanti al kitsch colto: accosta questo autoritratto barocco-pop a oggetti apparentemente “minori” come un manichino-robot di sua creazione. Il risultato? Un gioco teatrale sul culto della personalità e sul volto come superficie da abitare – o da reinventare.
4. Rosa Barba, “Enigmatic Whisper” (2020)
Un rullo di pellicola si muove meccanicamente proiettando luce e frasi spezzate su una parete scura. Sembra non succedere nulla, ma succede tutto: il tempo si dilata, la narrazione evapora, e restiamo a osservare il silenzio che prende forma. Una delle opere più poetiche del percorso.
Curiosità: Barba lavora con vecchi proiettori analogici modificati. Alcuni elementi sonori dell’opera sono generati in tempo reale dai movimenti della macchina stessa. Un piccolo esempio di come il mezzo diventi messaggio.

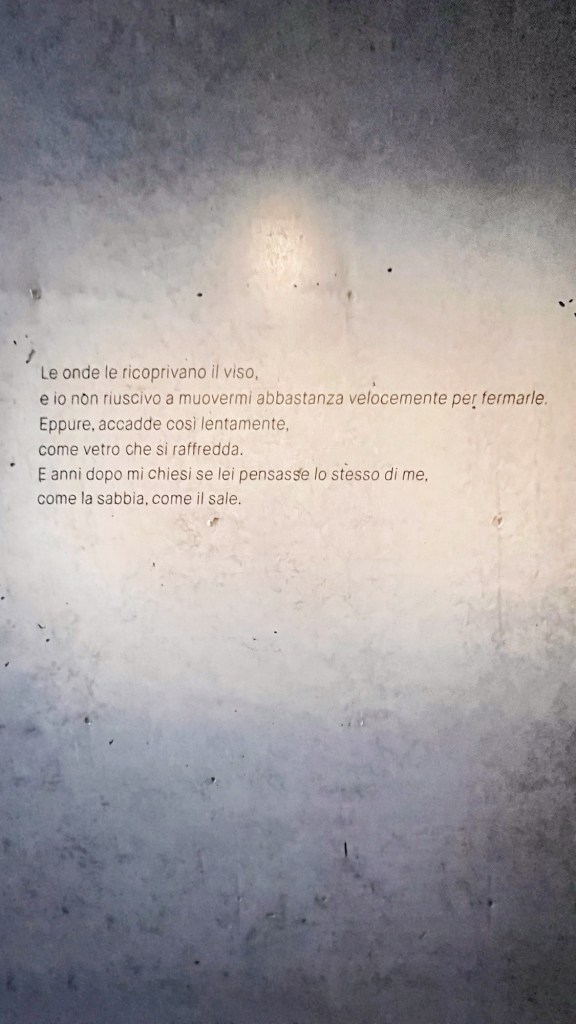

In un tempo in cui anche l’arte rischia di diventare consumo da scorrere in fretta, The Large Glass ci chiede una cosa rara: rallentare, soffermarsi, perdersi un po’. Guardare le opere senza sapere esattamente “cosa vogliono dire”, ma lasciando che qualcosa risuoni. Forse in modo (tra virgolette) “losco”, forse poco chiaro, ma sincero.
E in fondo, non è questo che ci si aspetta da un grande vetro? Che non ci restituisca solo l’immagine, ma anche una distanza, un dubbio, una possibilità di guardare altrimenti.
Torno in garage dal mio fil rouge! Ciao ciao!
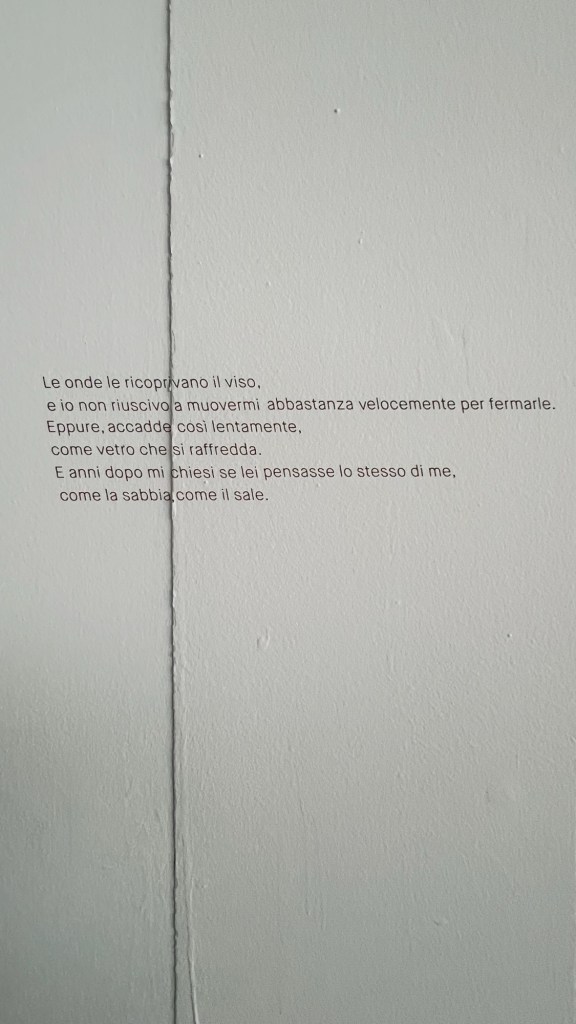
Nota a margine: una delle cose che mi fa più sorridere e pensare è leggere questi che spiegano le mostre come fossero cornucopie di significati intrinsechi, di linguaggi non detti, di non-visti, di schemi interpretativi epici, filosofici, evocativi. E poi, boh, magari quello che ha messo la sedia così è perché voleva solo riposarsi 😞
Scopri di più da
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.