
Ciao amiche e amici, come state? Io, dopo l’ennesimo trasloco (ho perso il conto), sepolto in casa tra scatoloni di libri: che fare? Apro per fare una cernita e spuntano loro, le letture “dei miei tempi”.
Se come me negli anni ’90 e Duemila avete apprezzato autori come Niccolò Ammaniti (il disagio giovanile raccontato senza pietà né sentimentalismi, con un uso forte della voce narrante e uno sguardo dolente ma mai pietoso, personaggi spesso ai margini, con genitori assenti o disastrati, tra droghe, sesso maldestro e un desiderio confuso di redenzione), gli altri Cannibali (Scarpa, Santacroce, Aldo Nove: linguaggio teso, iperrealismo, cultura pop, sperimentazione formale, voce autentica e brutale), Andrea Pazienza, in forma narrativa (non tanto nello stile, quanto nell’idea di adolescenza come trincea e sbandamento, come disegno espressionista della realtà) o il lungimirante e visionario Michele Lamacchia (surreale, critico, ironico, crudo, con i suoi incubi urbani, tra miserie sociali e riscatto personale), GAP – Grottesco Adolescenziale Periferico, il nuovo romanzo di Placido Di Stefano per NEO Edizioni vi suonerà subito familiare.
GAP sembra raccogliere l’eredità di quella narrativa italiana, riprende quell’energia, ma non è una semplice eco: la rielabora, evolve. Sporca il linguaggio con l’estetica del videoclip, i tratti del cinema indipendente (da Van Sant a Korine, dal Dogma 95 alla Nouvelle Vague) e l’immaginario adolescenziale post‑YouTube. Affonda nella malinconia senza compiacimento, aggiorna il racconto del disagio giovanile con una scrittura stratificata, capace di mescolare cinema, socialità spezzata e ricerca di senso. E lo fa senza nostalgia, ma con consapevolezza. Così GAP diventa un racconto feroce e insieme tenero, un flusso visivo dove l’adolescenza si consuma tra acting, abbandono, solitudini periferiche e la pulsione urgente di essere visti, se non capiti.
Ed è proprio da qui che vorrei partire con la NON recensione vera e propria, analizzando come Placido Di Stefano riesca a far emergere, dentro una narrazione frammentata e incalzante, l’esperienza cruda di Fedor, tra Milano periferica, cinema di formazione fai-da-te e una realtà che non concede scappatoie.
Il libro ha un ritmo serrato, da mixtape più che da romanzo, e si muove come una camera a mano impazzita che passa dai provini didattici alla strada, dai parchetti ai bar malfamati, dal dolore privato alla deriva sociale. Di Stefano scrive con la lucidità di chi ha vissuto certe notti in apnea e la follia creativa di chi sa che l’unico modo per raccontare queste vite qui è non filtrare nulla: né i dialoghi, né le paranoie, né il bisogno disperato di essere qualcuno in un mondo che ti tratta come un avanzo.
La voce narrante è tagliente, fluida, sarcastica, con quel tono da adolescente che ha letto troppe schede su IMDb ma nessun manuale di sopravvivenza. Eppure, proprio per questo, riesce a farti sorridere e angosciare insieme. Perché tra un’imitazione di Bogart e un’accenno alla Zombie Street di Philadelphia, GAP parla di dipendenze, solitudine, desiderio, inadeguatezza, famiglie rotte e sogni più sbilenchi di un piano sequenza di Harmony Korine.
È cinema fatto di parole. È adolescenza filtrata da una GoPro emotiva. È periferia vera, con le sue luci gialle, i cimiteri che brillano e store Intimissimi che diventano set per flirt falliti. È anche una riflessione profonda (ma mai stucchevole) su cosa voglia dire crescere in un’epoca in cui l’identità è liquida, instabile, e sfugge a qualsiasi definizione.
GAP – Grottesco Adolescenziale Periferico è un libro che arriva dritto, senza mediazioni, spinto da una rabbia precisa e da una sensibilità consapevole, capace di abitare le crepe invece che raccontarle da fuori, da una comoda distanza letteraria.
GAP è impregnato di immaginario cinematografico, come se i personaggi non riuscissero a percepirsi se non attraverso immagini, citazioni, posture prese in prestito da altri film e altre vite. È una narrativa che sembra scritta per essere vista, e che potrebbe convivere bene con il linguaggio delle serie post-2000 (da Skins a Euphoria passando per Breaking Bad, che viene citato esplicitamente).
Il protagonista, Fedor, ha sedici anni, una madre scomparsa, una sorella gemella e un talento per complicarsi la vita. Cresce in una Milano periferica e trascurata, fatta di campetti spelacchiati, bar di quartiere, strade senza sbocco e un orizzonte emotivo che si restringe ogni giorno. Intorno a lui, Leo, lo strafottente fragile, e il Moro, un regista in erba che parla come se stesse sempre girando il suo personale making of della disperazione, uno per cui la vita è un laboratorio permanente di acting estremo.
GAP non è una storia di formazione. È piuttosto una storia di trasformazione mancata, o meglio, continuamente abortita. Il libro è costruito come un patchwork narrativo: ci sono “track”, “provini”, “sperimentazioni”, flussi di coscienza, spezzoni di vita girati con una camera instabile. Il cinema è ovunque, come linguaggio e come rifugio. I ragazzi parlano e pensano per immagini, imitano pose, cercano in un’inquadratura qualcosa che dia loro forma. Ma alla fine restano sospesi, sfigurati, troppo veri per essere fiction, troppo confusi per essere realtà.
Il titolo dice tutto: è un romanzo grottesco (non per effetto comico, ma per deformazione esistenziale), adolescenziale (nel senso più crudo del termine, fatto di pelle scoperta, sbagli, eccessi, abbandoni) e periferico (non solo geograficamente, ma anche simbolicamente: GAP si muove ai margini, esplora il bordo sfilacciato della vita urbana, sociale e mentale).
La scrittura è tesa, stratificata, a volte allucinata. C’è un realismo spietato, ma anche una continua torsione lirica, quasi cinematografica, che accompagna il lettore in una dimensione dove il disagio è nitido, ma mai compiaciuto. Si sente l’influenza di certi film, ma anche un forte legame con la realtà italiana contemporanea, quella più marginale, quella che raramente si vede in letteratura senza filtri o derive sociologiche.
Non aspettatevi un plot rassicurante, né un finale edificante. Questo è un libro che non chiude, che non consola, ma che fa esattamente quello che dovrebbe: restituisce una voce a chi spesso non viene ascoltato.
E infine, sì: a mio parere di lettore mangione, GAP sembra raccogliere l’eredità di quella narrativa che ha avuto il coraggio di raccontare l’adolescenza senza infiocchettamenti, con una scrittura che rischia, che sorprende per la sua sincerità, per la scrittura viva e per lo sguardo che riesce a restituire, senza moralismi né estetizzazioni. Di Stefano porta tutto questo dentro un romanzo che, pur nella sua furia acerba e nervosa, intercetta un vuoto generazionale e lo restituisce con onestà, senza mai cercare scorciatoie letterarie. Se vi piacciono le storie che provano a dire qualcosa di vero anche quando fa male, questo romanzo merita davvero una lettura.
Torno a disfare scatole! Ciao ciao!
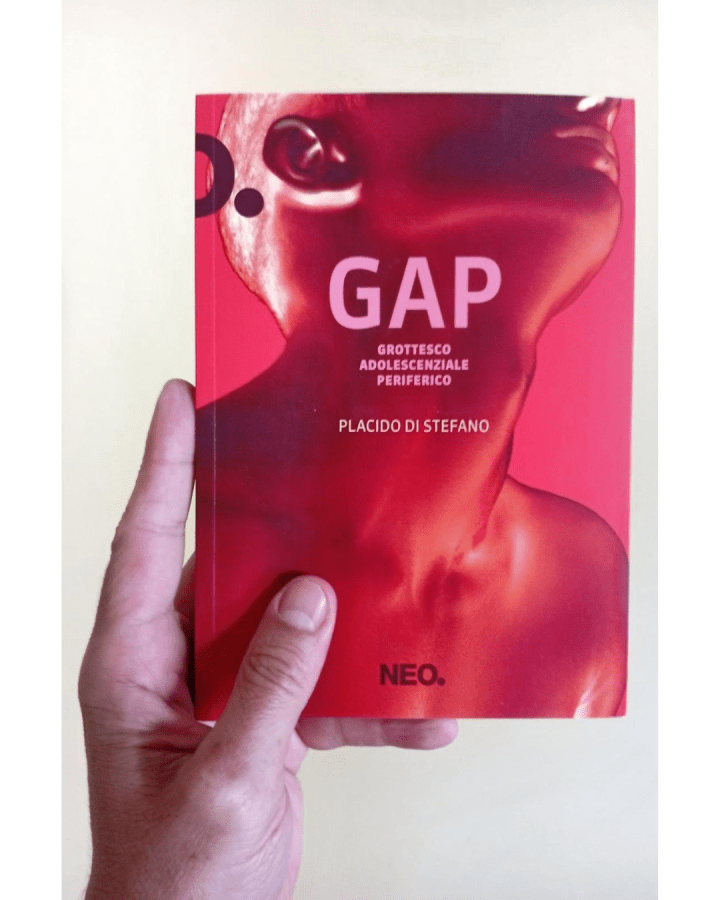
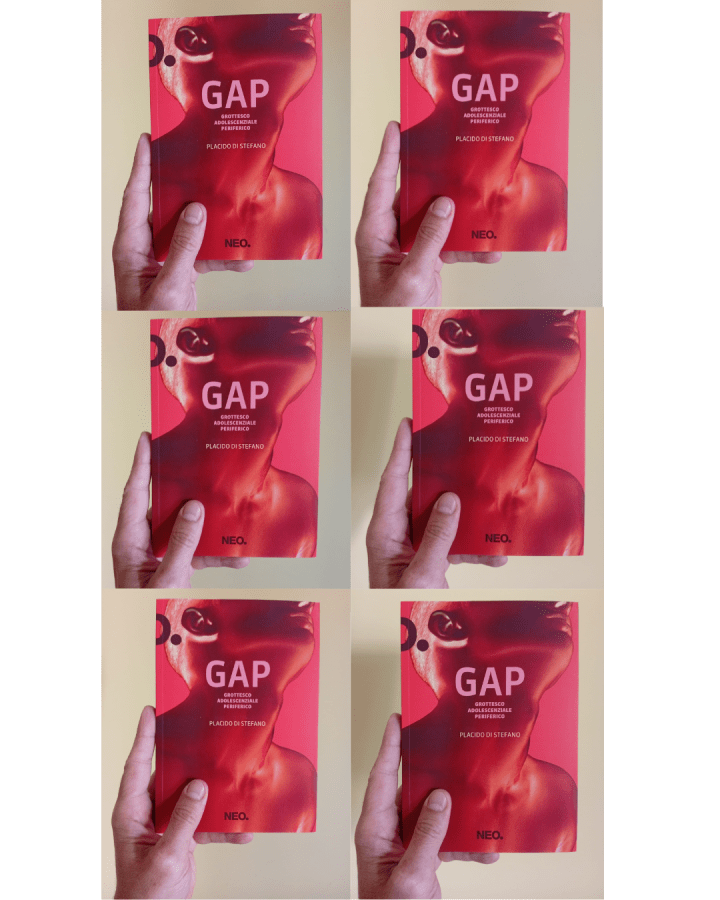
Scopri di più da
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.